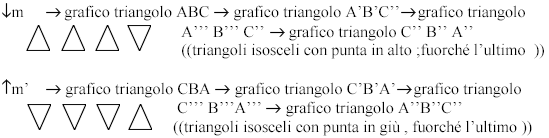dall’elevazione ad universalità di tutte le componenti di ciascun intuito percettivo loro corrispondente e in quanto unificate in una sfera che non ne escluda alcuna: un mondo in cui le percezioni fossero intuite in quanto attuate in tutto ciò che la loro potenza è in atto e in quanto quindi immobili e immutabili sarebbe l’ideale ontico per eccellenza in quanto totale ed assoluta coincidenza di reale e razionale: e io penso che il pensiero di Dio pensato da se stesso dovesse apparire ad Aristotele,, o meglio ancora a Duns Scoto con la sua ecceità, come una sorta di piramide alla cui base si sarebbero potuti scorgere nell’infinita ricchezza di tutta la loro varietà tutti gli individui presenti passati futuri, reali e possibili -possibili in quanto immessi all’atto dall’esclusione di ogni causalità impediente -, di tutte le classi, nella loro più assoluta delle perfezioni, tutti arricchenti con la loro realtà ontica che è intelligibilità totale, l’intelligibilità essenziale, ma pur sempre depauperata, dei razionali generici sovraordinati; e s’intende che in siffatto mondo ideale la negazione non può essere elisa, se per negazione s’intende quel che sul piano ontico corrisponde alla negazione fenomenica o di situazione umana: qui, negativo è esclusione di un rapporto di inerenza tra un sovraordinato ed un subordinato o di un rapporto di cogenerità tra due subordinati colatidudinari ed eterogenei, rapporto questo la cui esclusione è sinonimo di affermazione della loro diversità; là il negativo è esclusione di un’identità immediata o mediata tra due intelligibili a piacere e tra due intelligibili in genere, in forza o della differenza estensiva delle zone attuali e potenziali di ciascuna connotazione nel caso del rapporto di inerenza o dell’asimmetria delle zone attuali e potenziali nel caso di un rapporto di cogenerità, essendo la mancanza di negazione l’incastro reciproco di tutte le specie infime che darebbe vita al puramente intelligibile sfero parmenideo, incastro possibile di diritto, impossibile per realtà ontica, essendo la negazione l’autonomia assoluta di ogni specie infime nei confronti di tutte le altre, in forza del principio di ragione che dall’eteronomia essenziale degli intelligibili essenziali inferisce la liceità di determinazione dell’uno sull’altro solo per alcuni e non per tutti e da questa liceità la unificazione di alcuni solo in unità sintetiche razionali. Da questa differenza tra un platonismo in genere ed un aristotelismo promana la seconda delle disgiunzioni che la negazione, assunta a
punto di vista, impone di inserire tra i due. Si può affermare con sufficiente certezza che fin dai tempi più remoti, da quando il pensiero era già parola, ma non ancora scrittura, nella mente umana la nozione di reale non sia stata una ed univoca: anche se come classe abbracciava una sfera di enti ben più vasta di quella che oggi riteniamo lecito sussumere sotto di essa, pure è dato già ritrovare una traccia, ad esempio nei culti agrari, tra il reale in quanto pensato e il reale in quanto in sé, e un reale in sé in quanto di fatto e un reale in sé in quanto di diritto; tuttavia una determinazione intelligibile di siffatte distinzioni comincia a costituirsi col primo pitagorismo e con l’antagonista corrente eleatica, per la quale il reale in sé si pone uno ed univoco e contrapposto alla duplice classe del pensato di diritto e del pensato di fatto, essendo il reale in sé il reale in quanto determinato da una razionalità esclusiva e gelosa, essendo il pensato di diritto la rappresentazione del reale a razionalità esclusiva e quindi l’intelligibile in quanto intelletto, essendo il pensato di fatto la deformazione soggettiva che il reale in sé può patire per vari motivi e quindi l’intelligibile in quanto intuito sensorialmente. Se conserviamo questa tripartizione dopo averla spogliata di quel che di contraddittorio e di insufficiente l’eleatismo vi aveva lasciato, ci resta un reale relativo al soggetto conoscente il quale coincide con la sfera delle rappresentazioni, un reale assoluto o in sé o ontico a natura ontologica, un reale relativo ((relitivo??))) al reale assoluto o ontico a natura esistenziale: è lecito conservare una separazione tra i due ontici qualora si parta dal presupposto che nell’ontità si diano dell’universale e del particolare irriducibili l’uno all’altro, come pure è lecito negare la separazione dei due ontici sulla base del presupposto che ontico universale ed ontico particolare siano riducibili o il primo al secondo o il secondo al primo; poiché le due teorie metafisiche sia quella platonica che quella aristotelica argomentano una eterogeneità irriducibile tra l’ontico universale e l’ontico particolare, fin che si resta nel loro ambito tutte le cose debbono essere classificate o sotto il pensato o sotto l’ontico ontologico, che sarà l’intelligibile in sé, o sotto l’ontico esistenziale, che sarà il particolare mutuante la sua realtà almeno in parte dall’intelligibile in sé. D’altra parte entrambe le metafisiche asseriscono e dimostrano una struttura scalare sia dell’ontologico che dell’esistenziale: ed è appunto nel rapporto che tra scalarità dell’ontologico e scalarità dell’esistenziale esse pongono che platonismo ed aristotelismo ancora una volta divaricano: in un platonismo, se da un lato abbiamo la gerarchia dei generi e delle specie che è a portata ontologica e che vede i suoi livelli sottostanti depauperarsi via via in intelligibilità, come quelli che man mano scendono verso i grandi infimi
smarriscono la ricchezza razionale e con ciò lascian cadere sia dei contenuti intelligibili sia i rapporti unificanti i contenuti, e dall’altro abbiamo la gerarchia degli esistenti che ad ogni piano ricostituisce in molteplicità frazionata l’unità sintetica del piano sovrapposto fino a giungere al livello infimo che ripete per dir così l’intero livello supremo escludendo da sé tutti i fattori di unità che di questo fanno un uno, entro la sfera dell’ontità in sé le due piramidi si fanno equipollenti essendo in entrambe il moto dialettico dal vertice alla base e il moto dialettico dalla base al ((alla??)) vertice rispettivamente processo di degenerazione e processo di rigenerazione; che se poi le due gerarchie equipollenti vengono comparate con l’ordinamento scalare secondo cui la mente di condizione umana ordina le proprie rappresentazioni concettuali, allora i movimenti non risultano più proporzionalmente diretti: infatti, confrontate simmetricamente le due gerarchie, ad un momento delle gerarchie ontiche, il quale rispetto a tutti i subordinati risulta di tanto più ricco di questi quanto inferiore è la distanza che lo separa dall’intelligibile sommo, sicché la sua ricchezza sarà massima nell’intelligibile sommo e minima nelle specie infime, corrisponde nella gerarchia delle rappresentazioni un momento simmetrico che sarà tanto più povero rispetto ai suoi subordinati quanto minore è la sua distanza dalla categoria somma la quale risulterà dotata del minimo di connotazione di contro al massimo di connotazione delle specie infime: è logico, allora, che il moto dialettico di intelligibilità, tendente a ricostituire entro la rappresentazione del pensiero il valore dell’ontità ontologica, sarà dalla base alla vertice, come quello che muovendo dalla categoria somma ritrova in questa un minimo di essenziali universali e necessari mediante i quali è lecito cogliere tracce di universalità e necessità entro le specie sottostanti in forza del ricomparire nella connotazione di queste degli essenziali categoriale, e i quali vedono arricchirsi di nuovi universali e necessari via via che da un genere si scende attraverso le specie subordinate fino al livello speciale infimo dove la quantità di universali e necessari noti si fa massima e insieme inutile agli effetti dell’intelligibilità di qualcosa d’altro, mentre invece il moto dialettico a finalità esistenziale, tendente cioè a garantire una validità esistenziale ad ogni singolo piano gerarchico, è a senso opposto come quello che dal vertice procede verso la base, essendo gli intelligibili del vertice quelli che dotati di autosussistenza paiono donare la propria sussistenza autonoma agli intelligibili che vedono il proprio numero aumentare via via che si scende alle specie infime. In un platonismo, dunque,
indicato con i triangoli ABC, A’B’C’, A’’ B’’ C’’, A’’’B’’’C’’’
rispettivamente la piramide degli ontici ontologici, la piramide degli ontici
esistenziali, la piramide dei rappresentati in quanto intelligibili, la
piramide dei rappresentati in quanto esistenti si deve instaurare una equivalenza o
proporzionalità diretta tra la piramide degli ontici ontologici, la piramide
degli ontici esistenziali e la piramide dei rappresentati in quanto esistenti
giacché
in esse il moto dialettico discensivo è per dir così involutivo e degenerativo
e impone ad ogni salto scalare un impoverimento materiale che impone all’ontità
e insieme al pensiero di risalire ai gradi abbandonati onde ritrovare quella
ricchezza e completezza di ragioni sufficienti che il nuovo piano raggiunto ha
conseguito; di contro si deve instaurare una proporzionalità inversa tra le tre
piramidi suddette e la terza dei rappresentati in quanto intelligibili, per il
fatto che in quest’ultima il moto dialettico deve farsi ascensivo dalla base al
vortice ((vertice??)) per dar luogo ad un impoverimento di intelligibilità
universale, essendo il moto dialettico contrario quello destinato ad offrire la
pienezza dell’intellezione umana
S’intende allora che per siffatto modo di pensare la negazione non appartenga in genere alla sfera ontica nella cui zona ontologica la connessione costantemente inserita tra ogni generico ed ogni speciale comporta che nell’atto stesso in cui un genere vincola se stesso con una specie, questa sia sussunta ad esso oppur no indifferentemente in quanto la relazione di quel genere a quella specie trae seco la connessione simultanea di tutti gli altri generici sovraordinati a quel genere e assieme ad essa l’unità di tutti i subordinati entro quel particolare generico sovraordinato sussumente il genere cui la specie considerata è legittimamente sussunta - essendo F un genere