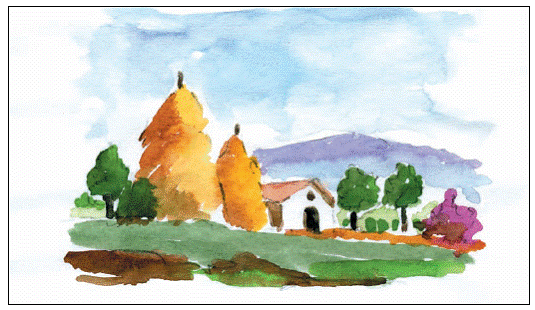
| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Michele Lacetera Persone Storie Parole IntraText CT - Lettura del testo |
La lingua italiana, da chi è appena uscito
dal tunnel del dialetto, è affrontata
come la prima lingua straniera della sua
pa’ s. m. pane. Evidentissimo il fenomeno
dell’apocope o caduta di un’intera sillaba.
Vuole l’articolo “lo”.
pacchiarottu, agg. sempliciotto, ingenuo,
paccutu, agg. di grande consistenza, di
pa’ de tritellu, s. m. il pane dei poveri,
impastato con il tritello che è un sottoprodotto
derivante dalla macinazione dei
cerali, usato di solito per l’alimentazione
animale. Il pane di tritello era completamente
nero.
pàdremu, s. m. con agg. poss. mio padre.
pàdretu, s. m. con agg. poss. tuo padre.
paìnu, s. m. bellimbusto, damerino. I
dizionari della lingua italiana registrano il
termine paìno con il medesimo significato
e tendono a definirlo un regionalismo
settentrionale, tanto da farlo derivare da
patavinum, padovano, di Padova. Il vocabolo
è rintracciabile nel sonetto “La
morte co la coda” del Belli dove si legge
“Si cce credemo, o mminenti o ppaini…”
Qui il termine è usato per intendere borghesi,
vestiti con abiti civili, appartenenti
pajacciu, s. m. 1) pagliaccio. 2) materasso
ripieno di paglia o di foglie di granturco.
Era quello più in uso nelle famiglie
contadine. La materia prima era fatta in
casa nel senso che ognuno era in grado di
procurarsi le foglie del granturco, coltura
onnipresente in ogni appezzamento di terreno.
palazzacciu, s. m. ampio fabbricato su
colle Palazzola appartenuto un tempo alla
famiglia Altemps. Questa famiglia, di origine
tedesca (nome originale Hoenems),
divenne assai nota a Roma ed ebbe grande
influenza nel mondo ecclesiastico allorchè
un suo componente, il cardinale Marco
Sittico Altemps, acquistò, a Roma, il prestigioso
Palazzo che ancora oggi porta il
cognome di famiglia. Il Palazzaccio, che
aveva una struttura da castello fortificato,
era usato per casino di caccia e per residenza
estiva. Si racconta che per un periodo
di tempo il poeta Gabriele d’Annunzio
usò il palazzo per i suoi convegni amorosi.
Il tempo e l’incuria hanno rischiato di
cancellarlo. Passata attraverso diversi proprietari
l’intera struttura è stata restaurata
ed ha acquistato un aspetto archittettonicamente
gradevole e ben inserita nella
realtà rurale nella quale si trova.
Palazzo Rospigliosi, ha origini alquanto
incerte quello che sicuramente è il reperto
storico più importante di Z. il simbolo
stesso del paese.
Si ha notizia della distruzione, avvenuta
più volte e per sfortunate vicissitudini, di
un castello che sorgeva lì dove oggi sorge
il Palazzo. Il castello venne completamente
distrutto alla fine del XIII secolo,
sotto il pontificato di Bonifacio VIII.
Diversi i proprietari: dai Colonna ai
Ludovisi fino ai Rospigliosi che ne vennero
in possesso nel 1670. Nel Palazzo si
svolse nel 1591 un consesso cardinalizio,
presieduto dal teologo gesuita padre
Roberto Bellarmino, durante il quale,
sulla base dei risultati del Concilio di
Trento, si provvide ad una revisione della
Bibbia. I saloni del Palazzo furono affrescati
da pittori della scuola romana legata
al fenomeno del manierismo. Ospiti del
Palazzo furono artisti, letterati, papi cardinali
e principi. Vittorio Alfieri e il grandissimo
Caravaggio in fuga da Roma tra
questi. Quando il Palazzo, per le mutate
condizioni storiche, cessò di essere il
cuore pulsante del paese, conobbe una
lenta ed inesorabile decadenza che toccò
il culmine durante le ultime fasi della
seconda guerra mondiale quando venne
utilizzato, prima come ospedale militare,
denominato ospedale internazionale, per i
soldati tedeschi feriti sul fronte di Cassino
e di Anzio e poi come struttura abitativa
per popolazioni sfollate provenienti da
diverse parti d’Italia. Nel 1981 il Palazzo
è stato acquistato dal Comune. La vendita
dell’importante immobile fu effettuata
dalla principessa Elvira Pallavicini.
Parzialmente restaurato ospita la Biblioteca
comunale, (v.) il Museo del giocattolo
(v.), l’aula delle riunioni del Consiglio
comunale e alcuni uffici. Vi si allestiscono
mostre, si tengono spettacoli, conferenze
e dibattiti. Diventerà sede della
Touro University (v.).
palepà, v. tr. 1) tastare, palpare. 2) sopportare,
lasciar correre. 3) risparmiarsi una
Palestrina, cittadina di circa 20.000 abitanti
a pochissimi chilometri da Zagarolo.
Strettissimi rapporti legano gli zagarolesi
a questa città che offre servizi indispensabili
come ad es. l’assistenza ospedaliera,
l’amministrazione della giustizia e l’istruzione
superiore. Questa dipendenza genera
un’ostinata rivalità tra le due comunità
che certamente non si amano. La città ha
una storia ricca di avvenimenti e la sua
data di nascita è incerta e si confonde con
le leggende suggerite da Virgilio, da Tito
Livio e Properzio che hanno fatto i nomi
di Ulisse e della maga Circe tra i suoi possibili
fondatori. Venne distrutta e ricostruita
più volte al tempo delle guerre
civili tra Mario e Silla e in tempi più
recenti durante le lotte tra le famiglie
Colonna e Orsini. Notevoli sono i resti
del grandioso tempio dedicato alla
Fortuna Primigenia. Palestrina si vanta di
aver dato i natali al principe della musica
sacra Pierluigi da Palestrina (1525-1594).
palletta, s. f. gazzosa. Il nome deriva dal
fatto che nella bottiglietta della gazzosa
veniva inserita una palletta che serviva a
impedire la fuoriuscita del gas e a mantenere
sempre gradevolmente gassata la
bibita. In questo caso si utilizza la figura
retorica della sineddoche in quanto si usa
una parte per il tutto.
pallinacciu, s. m. la pallina più grossa
usata nel gioco della “filaccetta” (v.).
pallocca, s. f. palla (di carta, di neve, di
stracci ecc.) Fig. 1) di una pietanza mal
cotta e indigeribile. 2) di una persona
rotonda come una palla tendente all’obesità.
Dim. “pallocchetta”.
palomba, s. f. cumulo di escrementi.
palu, s. m. canna usata nel vigneto per far
da sostegno alle viti. Ogni vignarolo ne
aveva a disposizione una certa quantità
dato che il vigneto era “servito” dal suo
canneto. Chi non aveva il canneto aveva
un debito inconfessabile tanto che si diceva
“igna senza cannetu è un debbitu
segretu”.
pampapatu, s. m. panpepato, dolce a
base di frutta secca, pepe e spezie varie.
panacca, s. f. sonoro ceffone.
pannaru, s. m. mercante di stoffe.
pannata, s. f. fiocco di neve.
panogne, v. tr. ungere, bagnare.
panondella, s. f. fetta di pane sulla quale
si lasciavano cadere le gocce di grasso
che colavano dalla pancetta messa ad
panondu, agg. sporco di grasso, unto.
Fig. perfido, cattivo, malfidato.
Pantanellu, s. m. Pantanello. Località
situata nel comune di Gallicano (v.) assai
frequentata negli anni passati dagli zagarolesi
che vi attingevano l’acqua leggermente
sulfurea di una fonte sorgiva. Vi si
andava con il carretto carico di barili. Vi
si riempivano anche bottiglie, fiaschi e
damigiane. L’acqua veniva usata per
curare dermatiti e generiche affezioni
cutanee. Si riteneva avesse qualità terapeutiche
anche per problemi intestinali.
pantàsima, s. f. fantasma. Reg. toscano
“fantàsima”.
pantàsimu, s. m. fantasma (maschio).
Fig. persona dappoco, sciocco.
panzarolu, s. m. “roffianu” (v.).
papagnu, s. m. pugno, cazzotto.
paparella, s. f. frutto del sambuco. I
vignaroli zagarolesi lo usavano e qualcuno
ancora lo fa per dare più colore al vino
rosso mescolandolo con le vinacce durante
la fase della fermentazione. Si diceva,
probabilmente esagerando sugli effetti
benefici della paparella, che essa conferiva
al vino colore, forza e sapore.
pappina, s. f. 1) una specie di sorbetto a
base di latte. 2) ceffone, schiaffo.
papponina (a), loc. avv. a zonzo, senza
meta, andare vagando senza costrutto.
parannanzi, s. f. grembiule da cucina
parghettone, s. m. soppalco.
pàrmare, s. m. palmer, tubolare di bicicletta.
Il sostantivo usato dagli zagarolesi
fino a qualche decennio fa è la deformazione
dizionari della lingua italiana per indicare
un tipo di pneumatico di bicicletta. Il termine
deriva da J. Palmer, fabbricante di
pneumatici in attività agli inizi del
Novecento. Dal nome del fabbricante alla
sua invenzione. Come chiamare Marconi
un apparecchio radio.
parmitta, s. f. pentola di rame, marmitta.
parmu, s. m. palmo, unità di misura
lineare in uso prima dell’adozione del
sistema metrico decimale, equivalente a
circa 25 cm.
parolaccia, s. f. se è vero, come ha scritto
Freud, che l’invenzione della parolaccia
ha contribuito all’affermazione della
pace tra i popoli e tra le persone, possiamo
affermare che gli zagarolesi hanno
dato il loro sostanzioso contributo, probabilmente
non più e non meno di qualsiasi
altra popolazione. La violenza racchiusa
in pochi suoni, la parola volgare usata per
colpire e far male. Così come per tante
altre parole anche per questo genere di
comunicazione c’è da dire che in tutta l’area
intorno a Roma e a Roma stessa i timbri
sono identici e che per mandare a quel
paese usiamo tutti un linguaggio pressochè
universale. Eccone un campionario: li
mortacci tei, fiju de mignotta (puttana,
troia, troiona, zoccula), fiju de ’na rotta
’n culu, te pozzano ammazzà, te pozzano
sperde, te pozzano accorà, te pozzano
accorà comme l’abbacchi, pozza morì
crepatu o schiattatu, ammorì ammazzatu,
te pijesse ’na occata de sangue, te pijesse
’n cancanu, te pijesse ’n corbu, te pijesse
’n corbu e campà, rottu ’n culu, muccu de
pippa, muccu de fregna, pezzu de fregna,
la fregna de mammota, de soreta.
pàrtone, s. m. cappotto. Paltò, dal francese
“paletot”.
pascipàsculu, s. m. porzione di terreno
pàsima, s. f. respiro affannoso, asma. E
anche affanno, ambascia, preoccupazione.
Der. di pasmo che sta per svenimento,
passettu, s. m. 1) tecnica seguita in alcuni
giochi di carte secondo la quale, per
trarre in inganno gli avversari, non viene
giocata una carta vincente. 2) attraversamento
di un posto obbligato da parte della
passone, s. m. grosso paletto di legno o di
cemento usato come sostegno per le viti.
pastella, s. f. focaccia confezionata con i
pastinatore, s. m. arnese di ferro usato
per praticare buche nel terreno per l’impianto
pastora, s. f. 1) moglie del pastore. 2)
pàtremu, s. m. con agg. poss. mio padre.
pàtretu, s. m. fusione dell’aggettivo possessivo
con il sostantivo, tuo padre.
patta, s. f. calcolo del ciclo lunare. La
“patta s’areccoje”. Der. di epatta che in
astronomia indica “il numero dei giorni
trascorsi dall’ultimo novilunio di un anno
al primo gennaio dell’anno seguente” Dal
greco “epaktè”, intercalare. (De Mauro)
patuja, s. f. pattuglia, mucchio, gruppo.
pece, s. f. pl. crampi alle gambe.
pecionata, s. f. lavoro malfatto, rabberciato.
pecione, s. m. in origine indicava il calzolaio,
colui che nel suo lavoro aveva a che
fare con la pece. Ora indica la persona
che non si dimostra in grado di portare a
termine, in maniera decente, un qualsiasi
lavoro. Superficiale, impreciso, trascurato,
pecorella de San Pastore, s. f. coccinella.
In alcune regioni italiane viene chiamata
gallinella del Signore.
pedagna, s. f. succhione che spunta alla
base dell’albero adulto, virgulto giovane.
Pedagnolo è un regionalismo toscano che
ha il medesimo significato.
pedarola, s. f. tralcio giovane che nasce
pède, s. m. piede. Al plurale cambia l’accento
pèdica, s. f. 1) radice grossa che va in
profondità. 2) fondamenta. In it. pèdica è
pedicone, s. m. fusto di una pianta unitamente
alle radici. Fig. apatico, svogliato.
pedicucciu, s. m. peduncolo.
pedocchiu, s. m. pidocchio. Fino agli
inizi degli anni Cinquanta il pidocchio
faceva regolarmente parte del paesaggio
zagarolese. Le teste dei bambini erano il
loro naturale rifugio e le bestioline venivano
combattute con la totale rasatura dei
capelli e con energiche strofinazioni a
base di petrolio. Il fastidioso parassita
non è mai completamente scomparso e
sistematicamente in un certo periodo dell’anno
scolastico tra gli alunni e il personale
della scuola si diffonde il panico
all’insegna del grido “Eccoli, ci risiamo”.
Controlli tra i capelli e cure preventive
pelà, v. tr. mondare, liberare della buccia
o della corteccia.
pelacciu, s. m. erba selvatica molto simile
alla gramigna.
peleputu, agg. polputo, carnoso, consistente.
pelle, s. f. rapporto sessuale, scopata.
peluccu, s. m. poveraccio, poveruomo.
peluccù, s. m. gioco di carte, una variante
del più noto gioco della scopa.
pennarolu, s. m. ragnatela, che pende.
pennazzià, v. intr. battere le ciglia.
pennente, s. m. orecchino (che pende,
pendente).
pennica, pennichella, s. f. pisolino
pennutu, agg. sospeso, obliquo.
peracottaru, s. m. a Roma veniva così
denominato il venditore ambulante di
pere cotte il quale era solito vantare a dismisura
la qualità della sua merce, anche
quando questa era di pessima qualità.
Oggi, ricordando questo particolare, la
parola è usata per indicare una persona
pasticciona che inanella brutte figure
pernucciu, s. m. peduncolo, picciolo,
perolu, s. m. piolo di scala, di sedia.
peromo, pr. indef. per ciascuno. “Famo
mezzo peromo de ’a vincita” disse il
Riccetto. (P.P. Pasolini, Ragazzi di vita).
persa, s. f. maggiorana, pianta aromatica
per insaporire alcune minestre.
perticà, v. tr. colpire, far star male. Di
preferenza riferito al freddo che “pertica”.
In italiano perticare significa colpire
perticasse, v. rifl. morire dal freddo, assiderarsi.
pesciararu, s. m. pescivendolo.
pescolla, s. f. pozzanghera.
pesulià, v. intr. far da contrappeso, bilanciare.
pettenicchia, s. f. castagna piccola e
pettine a tredici, s. m. componente del
telaio consistente in un pettine con tredici
pettinicchia, s. f. pettine con denti molto
stretti usato un tempo per la cattura dei
parassiti che si annidavano tra i capelli.
Fig. riferito a bambina vivace, dall’indole
pettorina (a), loc. avv. con il viso esposto
al sole.
pezza, s. f. persona poco raccomandabile.
pezzutu, agg. appuntito. Gli alberi “pezzuti”
sono i cipressi, simbolo dei cimiteri.
“Annà a l’alberi pezzuti” significa morire.
piantinaru, s. m. semenzaio.
piantone, s. m. barbatella.
picca, gioco di ragazzi a squadre. Si sceglievano
due pareti contrapposte e vicina
ad ognuna di esse prendevano posizione
le due squadre. Bisognava violare la parete
avversaria toccandola. Occorreva maestria
nell’evitare gli avversari, tempismo
nello scatto e una buona base di velocità.
Il gioco era assai rumoroso in un crescendo
di urla e di contestazioni. Quando un
giocatore riusciva a toccare la parete
avversaria gridava, esultante, “picca!”.
piccà, 1) v. tr. beccare. In un italiano
poco usato piccare vuol dire battere, percuotere
come fa la gallina quando mangia.
2) esprime le qualità piccanti del
piccio (dà de), fr. id. dare inizio.
pìcciula, s. f. bottone. Probabilmente
mutuato dal regionalismo toscano “pìcciolo”
che sta per moneta di basso valore,
di pochi centesimi. Siciliani e calabresi
dicono “i pìcciuli” per indicare i soldi in
pìcciule (a), loc. avv. gioco di bambini
con i bottoni. Scelto il terreno di gioco, si
provvedeva a sistemare i bottoni per terra
tutti nello stesso verso. Il giocatore sorteggiato
tentava di capovolgere i bottoni
premendovi sopra un dito bagnato di saliva
per aumentarne la vischiosità. Ogni
bottone capovolto diveniva proprietà del
giocatore che era riuscito a rovesciarlo.
picciuloccu, s. m. grosso bottone.
picculà, v. intr. fare giravolte, girare su se
stessi come un “pìcculu” (v.).
pìcculu, s. m. trottola di legno usata dai
bambini in alcuni giochi. Arrotolata una
cordicella alla parte superiore, la trottola
veniva lanciata verso terra. Se il lancio
era stato effettuato a regola d’arte, il giocattolo
cominciava a girare velocemente
su se stesso. A questo punto un altro giocatore
ripeteva l’operazione e cercava di
colpire la trottola avversaria. Quando il
colpo riusciva la trottola colpita si spaccava
e si riduceva in due pezzi. Il gioco si
chiamava “spaccapicculi”. Per rendere
più difficile l’opera di distruzione dell’attrezzo,
ogni ragazzo provvedeva a guarnire
la propria trottola con un “bullettone”(
v.), una specie di corazza protettiva.
pignoccatu, agg. fatto con i frutti della
pigna, con zucchero e pinoli. La pignoccata
è un dolce simile ad un torrone morbido.
In Sicilia è un dolce a forma di
pigna a base di miele e pinoli.
pila, s. f. pentola di coccio con manici.
Lat. pila, tinozza. “Ciavete una piluccia
mezzanella?” (G.G. Belli, Le chiamate
dell’appiggionante).
pilocca, s. f. pentola di terracotta molto
pilotto (da’ er), infastidire, innervosire,
dare sui nervi. In italiano il pilotto o pillotto
è “il mestolino con beccuccio che
veniva usato per versare sopra la carne
cotta sullo spiedo il grasso di cottura” (De
Mauro) L’azione descritta viene espressa
pìmpina, s. f. castagna selvatica non
commestibile. Si tratta di castagne non
innestate, di piccole dimensioni quasi
impossibili da mangiare perché non si
riesce a pulirle e liberarle della peluria
che le ricopre.
pimpirinella, s. f. pimpinella, pianta
erbacea dalle foglie arricciate e profumate.
Buona in insalata. Appartiene alla
piòito, p.p. del verbo piovere, piovuto.
pioizzicà, v. intr. piovigginare.
pipinara, s. f. coll. moltitudine di animali
e anche di bambini rumorosi e chiassosi.
pippa, s. f. 1) pipa. 2) masturbazione
maschile. Fr. id. “farsi una pippa” (masturbarsi).
3) persona noiosa e inconcludente.
4) discorso insopportabilmente noioso.
pìrula, s. f. 1) pillola, pasticca. 2) rumorosa
scorreggia. 3) sonoro ceffone.
piscarà, v. intr. perdere, lasciare uscire,
sgorgare. Es “la otti pìscara” (la botte
piscarellu, s. m. piccolo getto d’acqua o
di altro liquido.
pìscaru, s. m. getto, zampillo di un qualunque
pista, s. f. 1) orma, impronta. 2) luogo
all’interno del bosco comunale dove si
organizzavano trattenimenti danzanti.
Occasione di incontri, una delle poche
possibili, tra ragazzi e ragazze quando i
rapporti tra persone di sesso diverso erano
pistà, v. tr. 1) picchiare violentemente. 2)
correre ad alta velocità. 3) pigiare l’uva.
pistarecciu, s. m. impronte lasciate da
persone o animali su terreno o altra superficie
pistarola, s. f. una sorta di pigiatrice consistente
in una tinozza stretta in basso e
larga in alto con il fondo bucherellato. Vi
si pigiava l’uva con i piedi. Il mosto che
poi veniva raccolto nella botte fuoriusciva
da un’apertura detta “l’uscettu” (v.).
pistellu, s. m. pestello, utensile da cucina
a forma di pistone usato per pestare il sale
grosso o gli aromi nel “mortale” (v.).
pistelluccia, s. f. pl. nocche delle dita.
pitàrtima, s. f. coriandolo. Pianta che produce
frutti simili al pepe in grani. Con questi
si condiscono i “tordi matti” (v.).
Appartiene alla famiglia delle Ombrellifere
(Coriandrum sativum). I suoi frutti sono
pìttima, s. f. in italiano è un cataplasma,
un decotto di erbe aromatiche e in senso
figurato indica persona noiosa e insistente.
In questo secondo senso la parola è
usata a Z. e in tutta l’Italia centro-meridionale.
pizz’e pulenta, s. f. focaccia confezionata
con farina gialla di granturco. Cotta
sulla brace veniva spesso farcita con verdure
di diverso tipo. Per molti anni nelle
famiglie più povere ha sostituito il pane.
pizzutellu, s. m. varietà di uva da tavola
bianca e rossa dai caratteristici acini
allungati (pizzuti, appuntiti) comunissima
in tutto il territorio zagarolese. Coltivata
in pergolati. Uva cornetta. Una Sagra del
pizzutello nella vicina Tivoli.
poggiolu, s. m. muretto, muricciolo.
polepetta, s. f. muscolo della gamba e
anche polpaccio.
poleputu, agg. carnoso, polputo.
pollacca, s. f. camicetta da donna o giacca
a vita. Nella moda del primo Ottocento
la polacca era una giacchetta femminile e
anche un corto pastrano maschile.
pollastru, s. m. galletto giovane, pollo.
Fig. persona sciocca e troppo ingenua. Si
usa anche il termine “pollastrone”.
ponta, s. f. punta, estremità.
poracciu, agg. poveretto, poveraccio,
porcacchia, s. f. piantina erbacea dalle
foglioline grasse, nasce spontanea su ogni
tipo di terreno. Si può mangiare in insalata
unendola ad altre verdure. Usata una
volta per preparare il pastone al maiale. È
la “portulaca oleracea” della famiglia
delle portulacacee. Ha proprietà depurative
e diuretiche. Per uso esterno è efficace
contro dermatiti, orticarie, foruncoli e
porcu, s. m. maiale. Dim. porcarellu.
Diversamente da altre zone dell’Italia
contadina dove indifferentemente se a
Nord al Centro o a Sud il maiale costituiva
elemento importante nella stringata
economia degli anni passati, a Zagarolo
non è stata la stessa cosa. Interessi, attenzioni,
preoccupazioni rivolte in un’unica
direzione: la ‘igna, nient’altro. In poche
famiglie il maiale era allevato e le sue
carni lavorate. Per lo più famiglie provenienti
dalla vicina Ciociaria. Salsicce,
prosciutti e bistecche. Nelle norcinerie si
lavorava il sangue del maiale per la confezione
del sanguinaccio (v.).
porellu, agg. poveretto, sfortunato.
porporina, s. f. l’involucro che contiene
Porta Rospigliosi, il vero ingresso al
paese prima della costruzione del quartiere
chiamato borgo, la porta venne fatta
erigere da Marzio Colonna per celebrare
la vittoria di Lepanto (1571) in cui i
Colonna ebbero parte importante. Un
vero monumento celebrativo per accrescere
la gloria dei Colonna allorché
Marzio, siamo agli inizi del Seicento,
mise mano al rifacimento di buona parte
del paese. La porta è un mirabile insieme
di tufo e marmo con l’utilizzo di reperti
archeologici di epoca romana rinvenuti in
zona. Ricche decorazioni, busti marmorei,
bassorilievi e statue di diversa grandezza
costituiscono un’opera di grande
armonia e grandiosità. Quando il feudo
passò nelle mani dei Rospigliosi la porta
Porta San Martino, l’ingresso dalla
parte nord del paese. Innalzata ai primi
del Seicento per celebrare degnamente la
gloria ottenuta dalla cristianità a Lepanto
e, in particolare, in omaggio a papa
Martino V, Oddone Colonna, quasi compaesano
Genazzano (v.). A questo papa, divenuto
poi San Martino, gli zagarolesi furono
particolarmente devoti tanto da dedicargli
un’intera zona del paese denominata
Borgo S. Martino. La porta è una costruzione
imponente delimitata da due bastioni
merlati. Un grande stemma della famiglia
Rospigliosi, un busto di marmo raffigurante
“la regina”, (v.) decorazioni di diversa
natura, raffigurazioni di armi e altro ancora
contribuiscono a rendere unica e di
sicuro interesse architettonico questa
grandiosa realizzazione seicentesca.
portone, s. m. ce ne sono alcuni a Z. che
portano il nome delle famiglie che vi abitavano
nel passato. Si ricordano il portone
Maraccio, il portone Martini e quello detto
dei Telari. Analogamente a famiglie di una
certa importanza che possedevano immobili
sono state intestate vie, piazzette e
vicoli in diverse parti del paese. In tal
modo si spiegano le intitolazioni seguenti:
piazzetta Agostini, vicolo Bianconi, vicolo
e piazzetta Brembi, vicolo Giuliani,
vicolo Lezzi, vicolo Mariani, piazzetta
Minciacchi, piazza Paparelli, piazzetta
Vernini, vicolo Marinelli e altri ancora.
portugallu, s. m. arancio e il frutto di tale
poru, agg. povero (forma contratta).
L’aggettivo di solito precede il nome dei
defunti quando questi vengono ricordati.
posta, s. f. 1) ciascuno dei clienti del
vinaio presso il quale il carretto prima e il
camion poi effettuava una sosta per scaricare
il vino proveniente dalle vigne di Z.
Il luogo e la persona si confondevano e
diventavano un tutt’uno. 2) il luogo tra i
filari della vigna dove si formava il mucchio
delle canne nuove destinate a sostituire
postale, s. m. autobus per il trasporto di
postema, s. f. qualcosa di guasto che
emana cattivo odore. In senso figurato
affanno, preoccupazione, dolore. Postema
in it. è un termine medico ormai poco
usato per dire ascesso. In latino (Plinio) si
trova apostema con questo significato. Si
noti l’aferesi cioè la soppressione della
prima lettera.
posti, s. m. pl. le basi fatte di legno o di
muratura sulle quali si sistemano le botti
nel tinello.
Pozzarola (piazza), l’attuale Piazza delle
bellezze dove un tempo c’era un pozzo da
cui la popolazione attingeva l’acqua per
pozzolu, s. m. 1) recipiente di pietra di
forma circolare usato per farvi mangiare
il maiale. 2) cavità al fondo della cisterna
al punto di maggiore pendenza, contenente
poco più di un secchio d’acqua. Vi si
raccoglieva il terriccio. Quando si ripuliva
la cisterna, il prosciugamento del pozzolu
era il segno che la cisterna era completamente
pozzu, s. m. pozzo. In tutti i poderi c’era
il pozzo che era la riserva d’acqua necessaria
alla conduzione delle pratiche agricole.
Erano scavati a mano, profondità media
intorno ai dieci metri, venivano chiamati
pozzi romani. Per disporre di quantità di
acqua sempre più cospicue molti proprietari
hanno scavato pozzi artesiani con le
moderne tecniche di trivellazione del terreno
fino a 150 metri e oltre. Trivellazioni
avvenute senza alcun controllo e nessuna
attenzione alla salvaguardia del suolo.
Attualmente sono in vigore disposizioni
regionali che dettano una precisa normativa
tendente alla tutela del suolo.
pozzu de la ne(v)e, loc. s. m. località situata
nella valle della Servicola dove veniva
raccolta la neve che dopo essere stata
pestata si ghiacciava e durava a lungo. Era
una riserva di ghiaccio che veniva dato a
chi ne faceva richiesta. Si dice che se ne
serviva l’ospedale. Secondo altri l’espressione
era soltanto un modo di dire per
significare che in quella località, per la
caratteristica esposizione a nord, il freddo
era tale che la neve, quando vi cadeva,
durava a lungo e stentava a sciogliersi.
pratozzu, s. m. praticello.
preciuttu, s. m. prosciutto.
precoju, s. m. ovile, recinto per il bestiame
e in particolare per le pecore. Con tale
termine si indica anche un mucchio indistinto
dell’Italia centrale usato soprattutto nella
campagna romana. Probabile derivazione
del latino “perichorium” dal greco “perikorion”
che vuol dire limitrofo, contrada
intorno. “Dio me ne guardi, Cristo e la
Madonna/ d’annà ppiù ppe ggiuncata a
sto precojo” (G. Belli, Er deserto, dai
Sonetti). Qui il “precojo” è la cascina
dove si fa il formaggio.
predicolle, loc. avv. ai piedi del Colle
prémitu, s. m. lo sforzo che si fa quando
si incontrano difficoltà ad evacuare le feci.
Nel linguaggio medico il premito è “lo
spasmo dei muscoli dell’addome, dell’intestino
e dell’utero” (De Mauro) Con questo
termine si denomina anche la diarrea.
premùticu, agg. primaticcio, precoce.
prescia, s. f. fretta. Diffuso in tutta l’Italia
centro - meridionale. Lat. “pressia” der.
presemarina, s. f. rosmarino.
prèula, s. f. sgabelletto a tre piedi usato
soprattutto nelle operazioni della mungitura.
proìbbitu, s. m. scostante, inaccostabile,
pericoloso. La parola deve essere pronunciata
come parola sdrucciola con l’accento
sulla prima “i”.
Pro-loco, l’organizzazione per la promozione
di attività culturali a favore del
luogo è stata molto attiva in paese fino
all’avvento del Comitato di Palazzo
Rospigliosi che in qualche modo l’ha
espropriata di molte sue competenze. La
sagra dell’uva, le feste patronali, il carnevale,
il ferragosto e molte altre manifestazioni
ormai le gestisce l’organismo che fa
capo al Palazzo. In qualche occasione si
riesce a creare una sinergia che vede la
Pro-loco e il Comitato fianco a fianco nell’organizzazione
di alcune manifestazioni.
pròsperu, s. m. fiammifero. Usato in
tutto il centro-sud. Prob. der. di fosforo.
Protezione civile, la sezione di Z. costituita
nel 1987 annovera 39 associati
volontari. Dispone di una sede e di alcuni
mezzi per il pronto intervento. Impegnata
nel soccorso alle popolazioni in caso di
calamità naturali e per la prevenzione e la
repressione degli incendi boschivi.
prungu, s. m. l’albero del pruno. Fig. sta
puca, s. f. 1) penna d’istrice. 2) gemma
da inserire nel porta innesto.
puiellu, s. m. manciata, quantità di cose
che può essere contenuta in una mano.
pulenta, s. f. polenta. Per moltissimi anni
la polenta ha costituito il piatto base della
cucina zagarolese. Se ne faceva larghissimo
uso dato che la coltura del granturco,
materia prima da cui si ricava la farina
gialla di polenta, era diffusissima in tutto
l’agro di Z. Un sacchetto di farina gialla
si poteva trovare in ogni casa; non occorreva
comprarla. Dall’impasto di farina di
polenta si ricavavano anche squisite
pizze, cotte alla brace e farcite di verdure,
anch’esse abbondanti tra i filari delle
vigne. La polenta veniva servita sulla
spianatoia e ogni commensale doveva
seguire un percorso determinato senza
invadere lo spazio riservato agli altri. Al
centro della spianatoia veniva sistemato
qualche pezzetto di carne di maiale con
tocchi di salsicce che erano stati usati per
pulicà, v. tr. pulire, togliere le impurità al
pummidoru, s. m. pomodoro. Fig. sciocco,
Pupa (santa), s. f. santa immaginaria
usata come falsa imprecazione.
pupazza, s. f. bambola. Usato a mo’ di
intercalare come una falsa imprecazione
pupazzu, s. m. persona poco seria e inaffidabile.
pupu, s. m. bambino, fanciullo.
puzzonata, s. f. cattiveria, bravata, sciocchezza.
puzzone, s. m. cattivo, malandrino, brigante.
puzzu, agg. guasto, ammuffito, andato a
male.
puzzunculu, s. m. anonimo, ignoto, sconosciuto,
le càsule
La dismessa stazione delle vicinali in totale abbandono, in attesa di nuova destinazione.