«Motus in fine velocior».
Se i due volumi
delle Laudi del Cielo, della Terra e degli Eroi, colla tragedia
pastorale La Figlia di Jorio, rappresentano lo zenit dell'opera
d'annunziana; subito dopo, quasi fosse stato annubilato dall'incenso
bruciatogli sotto le nari, come ad un idolo capriccioso, il Pescarese rispose
alle preghiere, ai voti, alli inni, ai regali del suo popolo misto,
coll'ingannarlo. Tutti si aspettavano meraviglie curiosissime, fiori
spettacolosi e miracolosi da quella pianta ingrassata ed allevata sulla più
tiepida terra della terza italianità; si ebbero invece corolle già sfatte prima
di sbocciare, poma già putride inanzi la maturanza.
Dal 1904, D'Annunzio
si ripete e ridà l'opera, già espressa, in una lenta e strana ruminazione;
quand'egli sarà preso dalla fregola dell'ascetismo, ricorrerà all'amico suo
Barrès per farsi lisciare lo stile troculento coll'untuosità di Boussuet e di
Fénelon; ed il cibreo, per il nostro buon gusto italiano, sarà più nauseoso e
meno digeribile.
Noi vedremo una Nave
– dico vedere, non udire – sgargiare ai diversi effetti della mecanica
teatrale, come mimodrama – lirico, imprestar i motivi di Basiliola alla Fedra;
noi leggeremo le oscene rigonfiature di Forse che sì, forse che no,
ridisporsi sopra lo scheletro rachitico di Il Piacere; noi, nel Martyre
de Saint-Sebastian, ci farem ricantare rimpicciolite, le rappresentazioni
sacre del nostro medio evo e li autos sacramentales spagnoli, non che i
quadri plastici stilizzati dalle diverse Passioni genuine francesi,
derivate dal jerodrama di Arnault de Gréban.
Dove se l'è fumata
invece il novellista saporoso, che ricalcò Maupassant, ma vi aggiunse fosforo e
sale e la ninfomania e la satiriasi meridionale d'Abruzzi? Nel centone
abruciato di Le Faville del Maglio, nelle sdilinquenti preziosità
casteggianti di La Leda senza Cigno? La Pisanella navigherà da
una Figlia di Jorio, con innesto di Nave, e perciò vi dolora la
sifilide cristallina; La Parisina ricopierà La Francesca;
fortunata lei, che le crome di Mascagni la faranno più villana e feroce, unica
naturalezza sincera acquistata; sicchè il testo scomparirà sotto le note, il
gridar de' cantarini, il fracasso della orchestra.
Ma, intanto, il
Divo, odorando il vento infido, aveva cambiato cappella; e, ridottosi in
Francia, dove i goccioloni abbondano, insieme alli intelligenti che... barano,
si rifaceva l'altare, il culto... e l'asse ecclesiastico. Per quanto non avesse
mutato modo di vita, gli giovò mutar aria; non si applicò a cura ricostituente,
ma l'ambiente lo favorì meglio. Vi furono de' giorni di calma riflessione ad Arcachon;
in cui, ripiegatosi durante la siesta sopra sè stesso; dopo d'aver lustrato per
le sue camere interiori in visita, e visitato ogni suo mobile più o meno
prezioso; dopo, insomma, il suo esame di coscienza generale, si persuase,
un'altra volta, della sua unicità, rappresentata nella facilità mimetica di
tramutarsi a richiesta de' capricci dei compratori: e... così tornò a fare.
Imagino il Divo,
seduto in poltrona, dinanzi una aperta finestra, che dà sulla irrequietudine
dell'Oceano, presosi il capo laureato in mano, chè la destra glielo sorregge,
il gomito appoggiato alla coscia, strologare la sua gloria, sul curvo orizzonte
atlantico e sentirsi tutt'uno colla gloria del sole che tramonta.
«Sì; il Sole
tramontava; era un enorme sacrificio cosmico che tuttti i dì regalava alla
terra e non mai si diminuiva per l'aurora ventura. Tale la sua inesausta
fecondità. Egli era tutto lirica; la bellezza materiata di parole sprizzava da
tutta la sua persona: non aveva centimetro quadrato della sua epidermide che
non trasudasse poesia; egli era una musica sola e perenne».
Di fatti, le
ostriche di1 Arcachon,
dicono abbiano una percentuale maggiore di fosforo in corpo che non li altri
molluschi della stessa famiglia pescati a Taranto: l'Abruzzese ne accorgeva
l'effetto: tal quale assorbisse la Lecitina, sostanza fondamentale dei
nuclei cellulari, perfetto bioplastico:
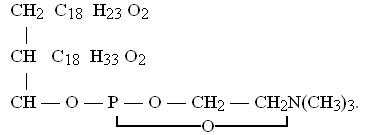
Col favor delle
ostriche d'Arcachon, rivide D'Annunzio i suoi valori passati e li risuggellò
nei suoi presenti bisogni: ostriche, ostriche a lui, come la Nanna dice alla
Pippa, nei mirabili giuochi dell'Aretino: «Perchè costoro inghiottonsi
l'ostriche senza masticarle, si pensano di far maraviglie»!
Sì che queste del
mar di Francia sono medicate per Mandragola, rinverginano e fanno concepire ad
un tempo: altro che allume di rocca e resina di pino ribollita insieme,
astringente massimo e sindectico! L'auto educazione di Gabriele eccelle quella
della Pippa; perchè egli è Talanta; solamente che colui, il quale si va
pensando – cinquantenne, – rassegna il suo mandato.
***
Illustre Maestro,
avete ragione: «O rinnovarsi o morire»; è uno de' vostri motti, che, col
«Per non dormire», contengono e riflettono la saggezza della vostra vita
e la venustà dell'opera vostra. Quando dobbiamo parlare di voi, non possiamo
mai dimenticarci che: «Voi appetite alle virtù del Camaleonte e le imitate»:
che: «Voi desiderate essere sempre sveglio ad ogni evento». Compiacetevi di
sapere che, però, altri, avendo una pelle sola ci tiene perchè appaja
sempre dello stesso colore; come, desiderando di far egregiamente le cose del
dì, non si abbandoni alla neurastenia, ma dorma di notte quanto conviene per
essere sano. Ma, per voi, che avete oltrepassato ogni cosa, ogni affetto, ogni
passione, ogni bellezza, fanno stato le novissime trovate: «O rinnovarsi o
morire; Per non dormire». Non usciamo dal compito che queste ci impongono,
e diamo un'occhiata al mondo, perchè è da questa esplorazione che voi
riconoscete quanto dovete fare di bellamente proficuo, oggi e domani. Bisogna
dunque servirlo secondo i suoi desiderii.
I Borghesi di questo
momento sono patrioti e cattolici: vogliono aspersorii e sciabole, come dieci
anni sono, battevano le mani ai drami di Tolstoi, di Gorki, ed ebbero un debole
per le bombe a domicilio. Lo scrittore se ne accorge, e, perchè ammette un enorme
importanza alle opinioni della propria clientela, – volete lavorare ad oggetti
fuori corso per quanto magnifici, ma non chiesti sul mercato? – le solletica;
o, per meglio dire, le riflette. Ogni dieci anni, il canone del bello e del
capolavoro letterario muta; perchè l'ideale del letterato è possibilista e
determinista, si foggia su quello di coloro che lo nutrono, cioè comprano i
suoi libri ed accorrono alle sue rappresentazioni. Date processioni e
battaglie, sciabole insanguinate di sangue infedele e santi sacramenti in
quarant'ore ed in parata.
Verso il 1890, ci si
poteva accostare, senza far ridere, al popolo: il canto mistico si interzava
sulla antifona: «Andiamo verso il popolo». Era un qualche cosa, questo popolo,
di misterioso, di confuso, in continua formazione e ribollimenti.
Avvicinandolo, vi accorgeste che era una perfetta realtà, tal quale, e ne
sentiste paura; conoscendovi homo homini lupus, cercaste d'ucciderlo al
primo incontro.
Male accorto! la
falsa democrazia, che si screpolava sopra la ganga terrosa dell'egoismo
intravisto per le fessure dal Popolo, vi fece riconoscere. Il Popolo vi
scoperse: scoperse che continuavate la serie dei giuocolieri e delli impostori,
che, da quaranta secoli, andavano in traccia sua per finirlo a bugie, già che
non era morto tutto di fame: ed il Popolo non vi fu grato. Non volendo
schiaffeggiarvi, chè una sola guanciata vi avrebbe polverizzzato, egli amò
lasciarvi crescere per divertirsi di voi; vi sibilò per farvi conoscere di
avervi indovinato. Da quel dì, puro esteta, abbandonaste, per le vie, le coccie
vuote delle bombe inesplose, seminaste, lungo il cammino, i detonanti di
Nietzsche e di Max Stirner, l'evangelio skopsa di Tolstoi, l'individualismo di
Ibsen e la bussola vostra segnò: «Barrès». Il Popolo non era composto di
comparse; tumultuoso, scioperava: avete mendicato, dai ministeri preposti
all'ordine pubblico, cariche di cavalleria. Male accorto ancora! I libri
vostri, che sono quelli dei borghesi, ebbero una vendita minore; perchè, a quei
borghesi, lo sciopero generale riduceva le rendite.
Ma poco fa vedeste,
dopo la massa grande, rigurgitare una densa poltiglia di Folla
maldigerita, dalle fauci aperte delle catedrali; Folla de' vostri simili,
femine e maschi borghesi, che si erano divertiti alle liturgie, come alle
pornografie della danza del ventre, o del tango, ballata a pelle nuda nelli
antri dove si fuma l'imbecillità dell'oppio e la pazzia dell'etere. Fu una
illuminazione, illustre Maestro; vedeste, tra quei più rauchi, Barrès; la
vostra bussola non segnava Barrès? Ed ecco il lituo abbaziale poggiarsi a palo
sul tricolore: tutta l'Italia ufficiale, e Borghese, che voi servivate,
furoreggiava colla novissima coccarda; e noi ridemmo all'arteriosclerosi che
rimbambiva. Voi aveste la vostra filosofia, che, dal Panismo panteistico, era
passata al Neo-idealismo bergsoniano; aveste il vostro critico, che vi fece il
massimo cantatore italiano, nel Croce; ed il resto delli imbecilli disse di sì.
Fu in torno a questo
tempo che morì, nelle coscienze professionali del giornalismo e fiscali del
governo, l'Imperativo categorico di Kant. Vi aveva vissuto tanto da
ajutare a produrre, da sette principati, pieni di pellagra e di ignoranza,
l'Italia; ed era ben necessario, che, riunite le membra sparse in una Nazione, questa,
per riconoscenza, dovesse congedare il buon senso ed il libero pensiero che
l'avevano fatta grossa come si trovava. Cioè, l'Imperativo categorico si
trasformò; non era morto: si necrotizzava; andava perdendo consistenza, si
spappolava, dimenticava la sua origine e funzione di decapitatore dei re; si
era fatto elegante, inglese, francese, italiano; aveva ancora delle arie
scientifiche; usava tuttora de' libri di bio-chimica, di psico-fisiologia, di
formule, di ruote di Savart, di apparecchi registratori; ma i risultati Bergson
li andava annotando sulle tabelle hegeliane, e si venne alle conseguenze di non
distinguere più azione da nozione, prete da fattucchiero, ciarle
da verità. Benissimo: vagiva l'Imperativo cadaverico, figlio di de
Maistre e di William James. – «O rinnovarsi o morire». – Tra li arredi
sacri, nelle sacrestie, colle Summe, le superstizioni, il lealismo,
l'aquila di Tarantasia, la croce delle croci, il triregno, il sillabo, la
verginità della Immacolata, si era riconciliata la fede colla scienza, la
monarchia col popolo, le arti colle fiere, il poeta con il ruffiano e il
ciurmatore: Alleluiah! il Tutto era tornato nell'Uno; Buddah si era
reincarnato, la Trimurti si affacciava sorridendo alla Trinità; il nero era
bianco e viceversa; l'Imperativo cadaverico si era raggrumato in Dio: la
transunstanzazione aveva operato un'altra volta, miracolosamente.
Illustre Maestro,
voi che, naturalmente, non capite queste cose, vedendovele porte dal vostro
cliente Borghese, afferraste di loro, semplicemente, la forma fisica: la
metafisica – che pare sia l'anima della filosofia – volò via; vi rimase nelle
mani: «1° La Bandiera tricolore, con tanto di stemma sabaudino – 2° Un piviale
a doppio uso, come ordina la liturgia, davanti bianco ed oro, per le allegrezze,
di dentro – la fodera – nero e argento – pei dolori – 3° Una specie di mannequin
anch'esso double-face, davanti e di dietro in perfetta funzione topica,
di novissimo Endimione, l'Ermafrodito di novissima ragione estetica
della modernità. Necessariamente, costui doveva portare nella destra il
bandierone di cui sopra, doveva vestirsi del piviale, che lo lasciava nudo
davanti, ma gli copriva il deretano, come quella parte che era di lui più
preziosa». – Illustre Maestro! le ostriche d'Arcachon sono aperitive!
Ecco l'Archetipo di
bellezza! Enfoncé Manzoni, che ci ha troppo annoiato ed irritato lungo
le pagine dei Promessi Sposi e per li Inni Sacri; via Carducci, per
comprendere il quale bisogna essere stato ad ammuffire sulle panche dei licei;
ma veder dentro l'invisibile, intendere l'inaudito, galvanizzarsi le cose
morte, far la vita morte, risuscitare, colla smania della novità cubiste e
futuriste, il medio-evo; questa, la più grande delle estetiche attuali.
La Francia, che
parve stanca di pensare cose giuste e di produrre cose belle, amando riposare
in una crisi muscolare, in cui lo sport prende voga, ed ha costume
rinnovato l'ignoranza, colla brutalità, trovò modo di applaudire al Mostro
venuto di oltr'Alpe, belluario delirante di passioni di testa e di inganno: gli
diede teatri, bardasse e soldi. Per lui, la ribalta dello Châtelet fu il suo
gemmato firmamento, dove spuntava la luna ed il sole nel medesimo istante, e,
similmente, tramontavano in confusa féerie.
Su quelle tavole
sceniche e polverose, in quel caos di telaccie guazzate e di lampade
intermittenti, si foggiò l'orizzonte ultimo erotico e letterario di D'Annunzio;
sorse la Rubinstein per logica degenerazione: era questa la Venere d'acqua
dolce, la Figlia di Jorio, la Basiliola, l'eterno feminimo
ossessionante, sconciatosi nella coda di pesce della Pisanella, che
continuava la sua fatture. Oggi, si rivelava con tutti li attributi ed i vizii
della complessa sessualità ermafrodita, in sul talamo della dramatica del
Pescarese. Si rievocava dal suo gusto, sempre insoddisfatto, per un di più
d'amare, per quello spasimo di quadruplice essenza, di sadica frigidità, quale
li abusati sensi di un cinquantenne desiderano, cacciano, eccitano, dalla
bavosa carezza al morso sanguinoso. Parigi, che è aperta a qualunque
inversione, accettava questa abnorme bellezza di castigo e di peccato, questo
San Giovanni – Bacco giovanetto, questa Ebe infibulata e fellatrice, stilitamente
magra. Era fatale che un dubio San Sebastiano riassumesse tutte le
femine del ciclo d'annunziano: era la nuova bellezza nevrastenica per li
ossessionati della etero-mania: Asta Nielsen2
l'autenticava dal suo regno del Cinematografo; la Pisanella l'avrebbe
contorta nell'agonia asfissiata e bruciata tra i fiori.
In questo punto
della vita artistica e della produzione d'annunziana, fermarsi a considerare,
per tutto, il San Sebastiano, come il miglior portato di un periodo di
completa decadenza, è determinare la anabasi gabriellina, la completa disfatta.
D'Annunzio, da quel
mimo in poi, non può più pretendere al nome di poeta, di creatore, di chi,
insomma, mette tutto sè stesso, col massimo abbandono, colla massima sincerità,
nella espressione di sè stesso: l'Opera. Egli non è più l'artista, ma
l'arteficie; il manuale che lavora di commissione, che fabrica il mobiletto
ricercato dalla moda, o dipinge quel fiorellino, con quel tal colorino, in quel
tal angolo di fazzoletto, con quella speciale grazietta che ci vuole. Certo;
non avrà designato padrone, ma un cliente imperioso ed anonimo: guai
all'artista che si è lasciato mettere il piede addosso dalla bestia feroce e
biblica che chiamasi Folla! Egli crede di dominarla, in principio,
perchè ne ha li applausi. La smania di riudirli, lo farà schiavo domani. Per la
Folla non vi ha che lo scudiscio: lo maneggi, il Poeta: repugneranno i proprii
contemporanei da lui; i nepoti gli rizzeranno statue come a loro padre
spirituale.
D'Annunzio potrà
avere statue in vita, come il Cavalier Marino, che domani saranno per essere
punti d'interrogazione sui trivi cittadini del mezzogiorno italiano.
In San Sebastiano,
dunque, si riassume la disfatta d'annunziana, assillata dalle folgori
reboanti e bombeggianti nel tricolore, del quale si ammantano le Canzoni
sopra le Gesta di Oltremare; che, oltre ad essere delle pessime terzine
sono anche una cattiva azione: di queste non ci occuperemo perchè compito più
di politica3 che di
critica; ma, coll'attardarci sulla bassezza del Mimo, avremo dimostrato la
mancanza di valore estetico di tutto il resto, che, dopo la Figlia di Jorio,
lo precedette e seguì.
1 È pur
d'Arcachon che venne l'epigrafe pei bersaglieri caduti a Sciara-Sciat, epigrafe
che si avrebbe dovuto apporre in Roma, in Trastevere, in faccia al Vaticano e
che suonava minaccia al Papismo. Venne sostituita da un'altra più melensa del
Conte bibliotecario Domenico Gnoli; e D'Annunzio, che secondo il suo comodo,
come per il San Sebastiano si professa cattolico, e per il Piacere
si fece pagano e fu a volta a volta anarchico, socialista, repubblicano,
radicale... papista, se ne lamentò. Qui vi diamo le due iscrizioni e la
protesta dell'Esule.
D'Annunzio: «Alla immortalità degli eroi – che il XXVI di
ottobre MCMXI – in Sciara Sciat – primi con vasto sacrificio – confermarono la
conquista necessaria – tutto il popolo di Trastevere – ottimo sangue romano –
consacra il suo voto – in questa sede della prodezza – che sta tra il Gianicolo
– onde placata scende l'ombra – del difensore di Villa Spada – e Ripa Grande –
su cui vigila l'aspettazione – d'un nuovo approdo fatale».
Gnoli: «Trecento bersaglieri – uscirono da questa caserma –
il 6 ottobre 1911 – accorrenti alla guerra di Libia – ed il 26 a Sciara Sciat –
avvolti da orde barbariche – combatterono fortemente – romanamente caddero – Il
popolo di Trastevere – che li acclamò partenti – ne benedice e consacra la
memoria – nel nome santo d'Italia».
Protesta: Ora il D'Annunzio appena apprese la notizia inesatta
della proibizione della sua epigrafe che si diceva dovuta all'«approdo fatale»
a Ripa Grande, mandò all'on. Gallenga, che l'aveva sollecitato a scriverla,
questo telegramma:
«Leggo del divieto nei
giornali. Tutte le ostriche di Arcachon ridono rumorosamente. È evidentissimo
ad uno scolaretto che l'approdo non può riferirsi se non al porto di Ripa
Grande. Trattasi di una allusione alla Magna Mater, significato mistico che le
diedi nell'Ode a Roma della quale i trasteverini dovrebbero infliggere la lettura
al proibitore. Mi meraviglio e mi dolgo del Comitato che questo consente. – Gabriele
d'Annunzio».
Dal Secolo del 20
Aprile 1912.
2 Vi servirà
meglio della mia prosa, questa giornalistica, che vi farà conoscere Asta
Nielsen, tanto più che la sentirete anche parlare d'annunzianamente, forse
senza saperlo.
LA REGINA DEL
CINEMATOGRAFO.
Berlino, Luglio.
Per poco che le fabbriche
tedesche di films esportino in Italia, il pubblico italiano conoscerà Asta
Nielsen.
Asta Nielsen è la fotografia artistica
fatta movimento, è, per ciò, l'attrice del cinematografo per eccellenza. Se ce
ne siano di migliori non so perchè io non sono un frequentatore appassionato
dei Kino-Theaters. Non per avversione o per ragioni estetiche, ma perchè il
cinematografo mi dà il mal di testa e perchè nei cinematografi tedeschi non si
può fumare.
Quanto al sacro rispetto
all'arte si può anche fare a meno di arrabbiarcisi; l'arte, la vera arte,
piglia oggi tante pedate anche nei teatri veri che una più una meno...
Del resto Asta Nielserr è una
artista nel suo genere. È veramente una artista. Io non ho mai visto una donna
posare con tanta disinvoltura e qui si tratta di posare sul serio e ridere e
piangere davanti a un obiettivo con tanta verità e al tempo stesso con tanta preoccupazione
che la linea nella fotografia riesca artistica. Asta Nielsen ha un sesto senso.
I suoi nervi prevedono la lastra e l'effetto della lastra. Ridere e piangere
non è mai una difficoltà per una donna. Moltissime donne ridono e piangono a
molto meno di cinquemila lire per sera, ma davanti a un uomo; e un uomo è
sempre più imbecille di un obiettivo e meno osservatore della linea di una collettività.
Oltre alla euritmia dei
movimenti sperò Asta Nielsen ha due tesori che la natura le ha prodigato e che
essa prodiga al pubblico con incomparabile grazia: la faccia e le mani. E
s'adatta al cinematografo anche in questo; che la sua bellezza, la bellezza
della faccia scarna e delle mani lunghe e sottili, è ora di gran moda per il
pubblico dei cinematografi, cioè per il gran pubblico, mentre per gli esteti è
già vecchia di dieci anni e non va più. Che abbiano la maschera di Asta Nielsen
io non conosco che tre donne: La Duse, Irma Gramatica e la Nielsen. Pensateci
bene, e vedrete che è in fondo la stessa cosa. La faccia è stata magnificata in
letteratura dai decadenti francesi e da Ibsen: Gabriele d'Annunzio l'ha
imbellettata all'italiana scoprendo il ricordo classico: la Medusa del Museo
delle Terme. È dunque per gli itallani la faccia della donna del periodo, chiamiamolo
meduseo, della letteratura dannunziana. Luigi Lucatelli giorni fa notava che
oggi la donna fatale deve avere gli occhi verdi. Lo assicurava discorrendo di
un volume di novelle dell'Ojetti. Ed è una osservazione profonda e giustissima:
la medusea è morta. E aveva gli occhi neri. Ma vive al cinematografo. La moda
delle faccie femminili non si spande con tanta rapidità quanto la moda dei
cappelli femminili. Ora le facce del D'Annunzio di una volta, di Bartholommè,
di Bistolfi, di Balestrieri pel pubblico dei cinematografi sono l'ultima
trovata.
La faccia delle meduse era
dolorosa; sembrava che il destino le avesse tormentate nella morsa del dolore o
della passione e che di questo tormento fosse rimasto loro qualcosa sul volto;
una faccia fatta d'angoli spasmodici e d'ombre. Asta Nielsen ha, parlando con
un redattore della National Zeitung, rivelato quale destino le ha
impresso sulla fisonomia il suggello doloroso: la miseria. Non è molto poetico
forse, ma ha l'aria d'esser vero. E serve a renderci più simpatica l'attrice.
«Volete sapere qualcosa della
mia vita?, ha detto l'attrice al giornalista; è una vita semplice come quella
di tutte le donne nate povere che combattono per vivere e di tutte le donne che
amano l'arte: vita di miseria, d'ostinazione, di lavoro e d'amore.
«Vi meravigliate che abbia i
capelli neri pure essendo nata in Danimarca? Il mistero è presto spiegato: io
sono zingara di razza. Mio padre era nato nello Jutland, ma da uno zingaro
boemo. Al pubblico fanno impressione i miei occhi perchè sognano sempre.
Sognano perchè si sono aperti sul Baltico. E anche la mia maschera dolorosa
impressiona?
«Vedete: mio padre era un
operaio ed è morto lasciando tre figli senza pane. Mia madre ci ha tirato su
facendo la cucitrice. Come? Imaginatelo voi. Io a quattordici anni ero in una
panetteria a vendere il pane a della gente anche più affamata di me. Eppure
imparavo a memoria i versi del Brand di Ibsen. È stata la lettura di Ibsen che
ha deciso del mio destino. Senza i versi del Brand sarei rimasta una operaia.
Così invece continuai a lavorare, ma la sera frequentavo una scuola di
recitazione. A sedici anni mi feci coraggio. Senza nessuna presentazione andai
a picchiare alla porta di Peter Jendorf. Era allora il più grande attore di
Norvegia. Ed ebbe la bontà di ricevermi. Non avevo che gli occhi eppure Jendorf
capì dagli occhi che ero una attrice. Mi fece studiare ancora, poi finalmente
mi ottenne il posto di caratterista al Nuovo Teatro di Kopenhagen. Gli affari
del teatro andavano male; il direttore era costretto a dare spesso delle
operette e chi non aveva voce da cantare doveva accontentarsi di poca paga e di
parti secondarie. In compagnia c'era Rudi Gad. Oggi è mio marito. Allora
cominciava il cinematografo. Durante una pausa Rudi scrisse la traccia di un
dramma di Cinematografo e le due parti principali le studiammo assieme. Poi ci
presentammo a Ole Olen il Re della films che ci accolse bene anche lui e ci
siamo sposati e abbiamo seguitato lui a scrivere e a recitare davanti
all'obiettivo io a recitare soltanto. Tutto è andato bene. Oggi sono Asta
Nielsen; milioni di uomini mi ammirano sulla tela bianca. A Pest quando sono
arrivata mi aspettavano diecimila persone; alla stazione i giovanetti per farmi
cosa grata avevano imparato a dire buon giorno in danese e mi applaudivano
così. Ma ben ricordo quanto c'è voluto. Lo sapete ora perchè mi è rimasta la
faccia dolorosa?
Poi, non vi dispiaccia di
collazionare il ritratto di Asta con quello della Rubinstein – Pisanella
– in versi francesi, che fan venire l'acquolina in bocca ai mille incontinenti
paralitici di Parigi: oh, sporcaccioni pederasti... di femine!
(Mme Ida Rubinstein, souple, harmonieuse, mime cette scène avec un art
consommé. Elle excelle à trouver les poses hiératiques qui font valoir les lignes
pures de son corps).
«Regardez-moi donc ces fuseaux des jambes,
cet orteil long, ces genoux minces comme
des osselets, ces hanches
qui semblent rétrécies par l'enroulage
des bandelettes,
cette gorge renflée à peine à peine,
pas plus que les bossettes
d'argent au mors de mon cheval, ces jeunes
bras où les muscles
sont resserrés comme les feuilles neuves
dans l'enveloppe
du safran blanc qui va fleurir, ce cou
droit, cette tête étroite
qui peut entrer en l'âme
par la moindre des fentes;
regardez-moi cela,
c'est de la bonne
façon d'Egypte,
messire le Génois.
Et vous le savez bien».
Sì: anche la bellezza patisce
i suoi quarto d'ora di moda; se volessi far dell'ironia, direi che la bellezza è
il solo quarto d'ora di moda. Ed oggi non sorge polputa e nuda e rosea e sana
dall'Oceano – era tanto facile ad Arcachon! – ma di sotto all'occhio
fotografico, o di sopra la ribalta. La Rubinstein comprende assolutamente tutto
colle sue gambe. Oh, Asta Nielsen, imperatrice dei Kino-Théatres, date, come
sapete, la nota giusta alla vera grand'arte per il pubblico – il quale si
abbandona, dimenticandosi, ad applaudire Shakespeare; – date il là della
dramatica internazionale, senza musica e parole: svestitevi, oh, Asta Nielsen,
oh, Rubinstein! Ma come siete magre ed isteriche ed avariate!
3 Troverete
questo saggio estetico-politico nel Secondo Tempo di Militarismo,
ossia «In Cerca di una Coscienza nazionale, sotto il titolo speciale Il
Tirteo Libicano. Qui mi importa di dirvi che codesto patriota in esilio
faceva costare alle cassette del Corriere della Sera L. 1200 – salvo
errore – ogni canzone: e le dava per poco. Comunque, mentre con Ragusa
Moleti, che volle fare a suo tempo il boia dei simbolisti e mandò alla
Salpetrière, da Baudelaire a Paul Fort, tutti i poeti francesi di quella
Plejade, colla giunta del D'Annunzio, oggi, ne fa il rosicchiatore e scrive
lunghe esegesi su quella sua epopea. Anche un giovanetto, Mario Pelorini
sfoga la sua ammirazione in un libercolo: Il cantore delle gesta d'Oltremare,
dove la sua ingenuità non gli fa torto, ma mi fa ridere. Dice tra l'altro il
suo feticismo che: «D'Annunzio è il più grande patriota che l'Italia possa
vantare; che è il suo cantore civile;... che è l'uomo, quel solo, che può e sa
interpretare tutto il moto di rinascita ed ardore di sua gente;... che è il
vate, il quale, colla sua strofa, infonde nuova vita e dischiude nuove
menti...» Balle! è il Padreterno della Menzogna.
Non è meno proporzionata la critica
francese, che soavemente canta e dà il ritmo dal Temps: udiamone un
sunto giornalistico:
«La spedizione di Tripoli –
scrive il Temps – permette all'Italia di conquistare una provincia e di
ritrovare il suo poeta. Gabriele D'Annunzio ha celebrato in terzine vibranti,
entusiastiche, in una lingua lirica e colorata, con immagini splendide, il
risveglio e lo slancio della Vittoria latina verso quelle rive africane su cui
un tempo si librò trionfalmente.
«A quindici giorni di
intervallo, egli ha dato al Corriere della Sera due canzoni di lunga
lena e di un bel soffio lirico. Dal lirismo di quelle strofe si può misurare
l'emozione e la gioia bellicosa del popolo italiano. D'Annunzio non ha fatto
che tradurre magnificamente i pensieri e le speranze dei suoi compatrioti, dei
suoi fratelli.
«Egli ha espresso il loro
sogno di conquista mediterranea in termini sonori e sfarzosi come le trombe
stridenti delle coorti imperiali. Forse gli stranieri penseranno che vi è una
singolare sproporzione fra il sogno e la realtà. Sembra che finora Giove
Statore abbia grandinato soltanto sulla sabbia: le aquile romane non sanno dove
posare il loro volo in quel deserto e non incontrano che magri allori. Ma sono
queste osservazioni da straniero. L'Italia vede la guerra con altri occhi.
Quando tutto un popolo comunica in uno stesso slancio, in una stessa fede, in
una stessa speranza lo spettacolo impone il rispetto.
«Bisogna soprattutto
considerare la spedizione di Tripoli come un simbolo e D'Annunzio non ha fatto
altra cosa. Nessuno più di lui era adatto a commentarla. Egli conosce
perfettamente le tradizioni e le leggende marittime del suo paese. Conosce
l'ambizione di Roma, un tempo soddisfatta di regnare sul mare come sulla terra.
Egli pensa che l'Italia deve riannodarsi al suo passato. Mi ricordo che un
giorno D'Annunzio mi diceva: – Sono un poeta navale. La mia prima opera di
poesia fu consacrata alle divinità marine. Durante la mia infanzia, trascorsa
sulle rive dell'Adriatico, salivo su di un brigantino che apparteneva a mio
nonno. La mia famiglia abitava presso Pescara, a Villa del Fuoco, a poca
distanza da un villaggio chiamato La Madonna del Fuoco. Nel giardino della
villa si incontravano qua e là delle ancore arrugginite che ricordavano le
vecchie galere. Il mio amore per il mare data da quel tempo. Oggi non posso più
farne senza; mi occorre il mare per pormi al lavoro.
«D'Annunzio è ora lungi dal
mare natio. Chi non ricorda l'esilio volontario e clamoroso del poeta, il quale
sembrava dire «ingrata patria non avrai le mie ossa»? D'Annunzio aveva scelto
la Francia come terra adottiva e, come per ottenerne la cittadinanza, le aveva
offerto il «Mistero» di San Sebastiano. Ma quando l'anima latina ha trasalito
al fragore delle armi, il poeta non ha potuto rimanere indifferente alla
emozione comune. L'ispirazione ha agitato il suo cuore in tumulto. Egli ha
afferrato la lira e il suo canto ha echeggiato al di là delle Alpi. La guerra
ha restituito alla madre patria uno dei suoi figli».
Il collaboratore del Temps
riassume quindi ampiamente le due canzoni e a proposito della leggenda del
calice contenuta nella «Canzone del Sangue» conclude dicendo:
«Come il calice, così
D'Annunzio tornerà certamente nella sua patria. Egli se ne era allontanato per
sempre, ma vi ritorna egualmente. È un miracolo del latin sangue gentile».
Per fortuna che ristabilisce
l'equilibrio, da «La Stampa», Bergeret, allora buon anti – d'annunziano,
oggi, non so, impoltronatosi a dirigere – Il Resto del Carlino bolognese,
dove il nazionalismo si è abbarbicato, i preti vi si sono intrufolati a
fornicare, i molti affrettati arrivisti dei diversi a spasso Sangiorgini si
mettono in mostra e son tollerati senza scandalo e vergogna. Bergeret,
dunque della prima maniera, non si nasconde per proclamarci:
«È l'ora delle gaffes
grossolane. Tale la famosa intervista sul San Sebastiano, in cui
buffonescamente si ripromise «di dare un contenuto nuovo alla santità»; tale
questa canzone dei Dardanelli in cui l'Italia è aizzata contro mezza Europa,
mentre ogni italiano da bene sente il dovere di raccogliersi, di vegliare e di
tacere. Leggerezze miste di imprudenza e di impudenza, a ciascuna delle quali
l'indelebile marchio sommarughiano riappare. Pare che D'Annunzio non sia mai
solo: che il magnifico signore della Rinascenza, primogenito di Cesare Borgia e
nipote di Zarathustra, conduca seco un compagno che lo ridicolizza, lo
svergogna e gli rassomiglia ahimè! come un fratello. È l'escogitatore delle
eleganze dannunziane così atrocemente abruzzesi; è l'inspiratore di quel
discoletto cinquantenne cui pare un gesto chic di non aver pagato il
sarto. È colui che trasfigura il grande poeta italiano in una specie di Gustavo
il Buonalana, vitajuolo molto considerato ai tempi del romanziere Paolo De
Kock. Ah! se Gabriele D'Annunzio, creatura apollinea se mai ve ne furono,
rimeditasse la grande parola di Delfo: «Conosci te stesso: tu sei il poeta del
gaudio orgiastico, non il poeta del casto sacrifizio alla patria. Conosci te
stesso: tu sei il cantore della concezione edonistica della vita: canta i
magnifici tiranni e le meravigliose prostitute e non tentare di comunicare alle
folle la febbre civile che non ti ha mai riarso. Conosci te stesso: tu hai
divinamente esaltato la dispersione dell'uomo nel vortice della vita animale,
la regressione alla bestia, alla pianta, alla natura inanimata: perchè simulare
quella superiore umanità che non possiedi? Sei Gabriele D'Annunzio: non
invidiare gli allori di Mario Rapisardi. Perchè le canzoni dei Dardanelli di
Mario Rapisardi, buon'anima, nella loro povertà fantastica e stilistica,
avevano una virtù che manca alla tua – la sincerità».
Ed io dirò, per esaurire
l'argomento in fretta: «In sui racconti, spampanati con tumida disinvoltura
dalli assoldati ed improvvisati corrispondenti dei giornali di guerra italiani,
ex liceisti e comediografi andati a male, poeti in fregola, gozzaniani e
stiracchiati, critici falsi e sgramaticati, dico i Bevione, i Civinini, i De
Maria, i Gray, i Coppola, eccetera, caterva magra, per dir bugia e per tenere ignorante
il pubblico delle crudeli e feroci verità; quest'esule per debiti ricerca la
materia prima del suo canto! È sulla prova e le indicazioni di questa cronaca,
che distende le sue terzine, ne fa incrociare le rime; è sui manoscritti
dell'ordine del giorno delli S. M. burocratici e militari, con un zinzino di
censura questurina al telegrafo, ch'egli assegna, come un funzionario di
poesia, medaglie poetiche al merito e le appunta sulle assise dei cari
bersaglieri di Gustavo Fara, su Pietro Ari, sulle poppe di Elena di Francia,
sui pettorali di Umberto Cagni, sulla Tomba di Mario Bianco. Le appunta, perchè
le ha coniate con sigillo parigino, giacchè le fuse da carta gazzettiera; di
fatti vi accorgete che non risplendono.
«E noi vorremmo credere, per
quanto non sia vero, che magnificar gesta di sangue, per l'opportunità dell'ora
che passa, per l'aumento di un orgoglio nazionalista e pretenzioso, possa anche
essere officio di poeta civile ed epico: ma, davanti al meschino risultato di
queste terzine plebee e gonfie di tropi ridicoli ed elefanteschi, foggiati
sulle superstizioni dell'altare, del trono, delle armi, delle forche, possiamo
giudicare che un'altra volta D'Annunzio si è illuso di raggiungere l'epica.
«No, egli non fu nè può
essere, nè sarà mai poeta di gesta civili e nazionali, perchè manca di quella
necessaria serenità e generosità per cui si riconoscono i diritti dei nemici e
dei vinti. Omero canta Achille ed Ettore insieme, Ulisse e Priamo, collo stesso
inesausto amore, colla stessa appassionata convinzione: qui, la grettezza
morale dell'ultimo Pescarese destituisce le sue canzoni dal Poema, le consegna
alla cronaca come poesie d'occasione, composte di improvviso, squattrinate
davanti al pubblico ghiotto – che illudono – settimana per settimana, per la
fabrica dell'appetito».